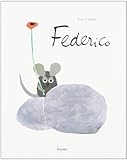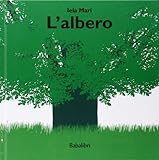Tratto da: “Fiabe Abruzzesi” di Domenico Ciampoli, trovi le altre fiabe della stessa raccolta qui.
Camminavamo a rilento; io su di un povero cavallo da nolo e il mio vetturino a piedi. Un sentieruzzo scosceso, pieno di ciottoli ci menava al guado del Sinello, le cui acque s’udivano scorrere fra i macigni pel cupo mormorio che brontolava da lontano.
Si faceva sera. Il sole indorava le case di un paesello – Gissi – posto al culmine dell’erta collina al di là del fiume, e ne facevi luccicare i’ vetri, i quali splendevano per un poco di luce viva e scintillante, e poi sparivano a mano a mano che il cavallo avanzava. Sulle alte siepi, che fiancheggiano tuttora la viuzza, s’udiva spesso un battere d’ali delle passere che andavano appollaiandosi, un pigolio di capinere, e più giù, là tra i pioppi della riva, il lamento di un rosignuolo, accompagnato dal monotono gracidar delle rane, venute su da qualche pantano che nel letto del fiume resisteva ancora ai caldi estivi.
Passammo il fiume proprio là dove un torrentello vi mette foce, e dà alla collina di Carpineto quasi la forma d’un delta o d’un isolotto formato nel bel mezzo della corrente; e cominciammo a salire.
Il sole era tramontato. Un’arietta fresca spirava tra le foglie degli alberi, ed io la bevevo, come l’arabo beve l’acqua d’un’oasi.
– Affrettiamo il passo – dissi al buon uomo che mi accompagnava. Temo di arrivare tardi… È vero che la sera è bellissima, ed il viaggiare di notte fa piacere, quando c’è il sollione di giorno; ma non voglio farmi aspettare.
– Non temete, signore: non ci resta che un paio d’ore di cammino; la strada è tutta buona, tranne questa salita che toglie il respiro, e poi, più su, quando si riprende il piano, la rupe della Zita.
Io aveva più volte inteso parlare di questa rupe, anzi vi ero più volte passato su per un sentieruzzo di terra calcare, sempre raccapricciando; ma non avevo mai avuto vaghezza di cercare la origine di quel nome strano più che bizzarro.
Ho detto che Gissi si stende sul culmine d’un colle erto, cenerognolo, scheggiato specialmente dalla parte che guarda tramontana. Da questa parte l’altura sì taglia a precipizio, ed una profonda, angusta vallata si stende buia buia laggiù. Chi passa lungo il sentiero che costeggia quell’orrido dirupo, sente drizzarsi i capelli; e la donnicciuola affretta il passo in aria di paura arcana e via trascorre facendosi il segno della croce. Qualche ginestra pallida va crescendo sull’orlo dell’abisso, tinto a color di basalto; e poi giù, in fondo in fondo, quasi a renderlo più torvo, ombreggiano alquante querce.
Ci avvicinammo a quel luogo. Io scesi da cavallo, e vòltomi al buon uomo:
– Sapresti dirmi – gli domandai – qualche cosa sul perché questa rupe é chiamata così?
– Che volete che vi dica, signore? Ne hanno fatto una storia. Chi la conta per dritto, chi per traverso: a sentirli quelli che ne parlano, c’è da dare torto a tutti o a tutti ragione: però, come accade spesso, i più si accordano sul fatto principale, ma si accapigliano in quanto al resto. Dice ognuno, per esempio, che su quel punto, là proprio dove la rupe è più alta, cadesse una ragazza che andava a marito. D’onde partisse, dove andasse, se fosse signora o contadina, che avvenisse dello sposo, e mille altre cosucce, ti pongono in un ginepraio da non trovarne la via: ciascuno si tiene dalla sua; e chi udisse me, così per dire, voi e due o tre altri insieme, perderebbe il filo di raccapezzarne più un’acca, e farebbe come avviene quando uno vuol distrigare una matassa, e un altro, in aria di trovarne il bandolo, l’arruffi di più.
– Dimmela dunque, come la sai tu, questa storia.
– A me, signore, la fu raccontata da mio avo, padre della madre mia, che era un uomo co’ fiocchi, buono a tutta prova, che Dio l’abbia in gloria. Aveva servito sotto
Napoleone: era stato non so in qual paese, dove c’è neve, neve e poi sempre neve da far restare li dritti i poveri cristiani, come statue di marmo. Era uno dei pochiscampati dagli stenti della fame e del ghiaccio. Aveva settanta anni e non ne mostrava cinquanta. A sentirlo, quando raccontava le guerre in cui s’era trovato, le ferite ricevute, i bei colpi dati…, gli sarei stato attorno tutto il mio tempo.
Una sera dunque, eravamo tutti raccolti accanto al fuoco e si sentiva sibilare il vento, e giù pel camino veniva un brontolare come di tuono; fioccava fuori e non s’udiva uno zitto, tranne il mugghiar del mal tempo; e il vecchio incominciò:
– Udite quei rumori? Non è solo il vento che li fa; sono anche le anime di alcuni morti che escono a ridda nel mezzo della notte, perché non fecero buona vita. –
Io sorrisi a quel dire semplice del credulo vetturino; ma egli continuò:
– E mi ricorda d’averne viste alcune, là, sui campi di guerra, dopo la battaglia. Vagavano in forma di fiammelle azzurrine, che mettevano spavento; anzi avvenne una notte che un mio compagno era di sentinella, e forse per riscaldarsi, se ne andava su e giù, quando vide seguirsi da una di esse. Si fermò e quella si fermò; tornò a camminare ed essa lo seguiva. Spaventato, lui che si rideva dei nemici, si fece il segno della croce e la fiammella disparve. Forse era l’anima d’un camerata con cui era venuto in uggia prima che morisse: ora forse gli cercava perdono.
Ed a proposito di queste anime disperate, vi dirò una storia avvenuta qui, fra i nostri monti, non lontano da noi.
Era su d’un picco scosceso, cinto di burroni, un antico castello, e in quel castello v’era una fanciulla. Tutti susurravano che il padre di lei fosse così tristo che non temeva più l’ira di Dio; anzi i più dicevano che avesse venduta addirittura l’anima al demonio; e ne faceva tante di male azioni, che quasi quasi si poteva dire essere venuto il demonio stesso ad abitare quell’altura. Ma la fanciulla era buona buona, come una colomba: somigliava tutta alla madre. Afflitti e poverelli dei dintorni ne avevano consolazioni e soccorsi; anzi li cercava ella medesima, tanto era caritatevole. Pareva una vera grazia di Dio, ed era bella, modesta e pia.
Un giorno capitò nel castello, forse per disgrazia di quella casa, un bel giovane cavaliere, alto, vigoroso e snello, ma bianco in viso come chi ha sul cuore mille sventure da piangere. Il vecchio signore del luogo l’accolse molto cortesemente; e gli offerse armi e scudieri, perché il giovane era figlio d’un amico di lui, che, nelle risse dei baroni d’allora, aveva perduto coi poderi arsi anche la vita. Ma i nemici del padre non contenti di questo, cercavano a morte anche il figlio, a cui era riuscito, dopo una lotta mortale, a porsi in salvamento. E là dimorò qualche tempo sempre pensoso, sempre afflitto.
Un dì parve meno triste, e cantò sul liuto una sua vecchia ballata. Sapete perché? Perché s’era innamorato e innamorato della figlia del suo ospite, del tremendo castellano. Ed ella pure, la povera fanciulla, si sentì corriva all’affetto e ricambiò l’amore.
Passarono giorni, passarono mesi; e nulla s’era sospettato di questo segreto. Guai, se quel vecchione orgoglioso avesse trapelato qualcosa! Egli era uomo da chiamar traditore il giovane cavaliero, e come tale, farlo appendere a’ merli del castello.
Intanto i nemici di quel povero giovane, appena ebbero scoperto il luogo di rifugio, avvisarono il modo di averlo nelle mani, meglio con l’astuzia che con la forza, perché sapevano di trovare dentro la rocca più leoni che volpi. Il figlio dunque del capo di tali nemici mandò messi segreti al castellano per chiedergli d’impalmare la figliuola; e poiché il partito era onesto e vantaggioso, il vecchio se ne tenne onorato, e senza dirne nulla alla ragazza, perché la sua doveva essere la volontà di tutti, rispose che contrarrebbe il parentado. I messi tornarono al loro signore e tutto fu conchiuso.
Intanto la giovinetta, ignorando ogni cosa, sperava di poter godere lungamente quell’amore innocente e puro che si chiama il primo. Ma il giorno delle nozze si avvicinava, e l’orgoglioso vecchio ne parlò alla moglie la quale fè conoscere alla fanciulla il volere paterno. A sentir questo, pianse la poverina, si disperò, pregò la madre…, ma tutto era disposto, e la sentenza fu irrevocabile. Come seppe ciò, l’ospite innamorato tornò cupo e silenzioso; perdeva in un punto l’asilo, l’amore, tutto.
Venne il giorno delle nozze: era gran festa nel castello: non si parlava che di gioia: i servi correvano affaccendati di su e di giù, e ogni cosa mostrava i preparativi della cerimonia. Intanto fra quei tripudii la giovinetta pallida, estenuata, pareva tornare dal sepolcro o andarvi più che a nozze. Quando tutto fu pronto, ella comparve nella sala: si firmava il contratto… ella scrivendo tremava… Aveva appena finito, che un grido di disperazione uscì fra i convitati ed un uomo, tutto vestito di ferro, sparve. La fanciulla impallidì ancora, poi svenne. Quando fu tornata in sè, si trovò da vicino la madre e lo sposo, che con riso infernale disse:
– Il ponte levatoio non è calato. Egli è qui: lo troveremo, e sarà punito della paura che vi ha fatta.
Passarono alcuni giorni, ed ella parve star meglio. Lo sposo premurò di condurla al suo maniero, e così fu fatto.
Una lunga fila di briosi cavalli faceva corteggio ai due giovani; nei villaggi si erano costrutto arcate di alloro e di fiori; per le vallate si suonavano i pifferi e le campane a festa; ma forse la fanciulla aveva un solo pensiero: – Dov’è l’amor mio? –
Arrivarono sulla rupe che ora chiamano della Zita. Era quasi sera. Alcuni valletti facevano lume alla via, e non s’udiva che lo scalpitar dei cavalli e il mugolar d’un po’ di vento là, sotto il precipizio, quand’ecco, non so donde, uscire un fantasima spaventoso, tutto lordo di sangue, afferrare la giovinetta alla vita e via perdersi con lei in un baleno nell’oscurità di quell’abisso. I cavalli impennati si diedero alla fuga, trascinando i cavalieri…
E non si seppe più nulla.
La dimane, alcuni pastori che passarono in fondo della valle, videro un bianco velo pendere da una ginestra…. Alla fine anche il velo sparve…. e di quel fatto ora non rimane altro che il nome della rupe.
Narrarono poi d’aver vedute a mezzanotte andare errando laggiù due bianche larve; risalire il dirupo, e poi sparire, come nebbia, nel cielo; e cambiarsi in due pallide fiammelle che guizzavano un poco e si perdevano poscia nella immensità delle ombre.
Erano la fanciulla e il cavaliere…
Quell’infelice fu trovato morto in un fossato del castello, nè mai si seppe chi l’avesse ucciso.
E qui tacque il buon uomo. Quella leggenda m’aveva messa in cuore una brutta malinconia; e quasi quasi mi sentivo commosso. In questo, una campana da Gissi suonò l’Ave Maria: tutto taceva intorno, tranne lo strido lungo e misurato d’un gufo, nascosto laggiù fra i rami delle querce… Volsi un ultimo sguardo al precipizio, e seguitai la via.
🎧 Ascolta le fiabe con Audible
Provalo gratis per 30 giorni e scopri centinaia di audiolibri per bambini e genitori.
Prova Audible gratis